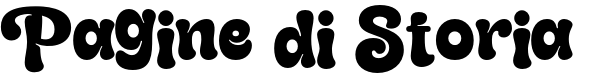La percezione che le cose nel mondo vadano di male in peggio va di pari passo con la convinzione che nulla possa fermare il loro corso. La convinzione deve molto a un pessimismo che è parte della nostra esperienza mondana e prende il sopravvento nei momenti di maggior disagio e sconforto: sentiamo il destino cattivo più potente del destino buono. Le azioni creative sono più difficili e vulnerabili di quelle distruttive e un evento catastrofico (naturale o di origine umana) può cancellare secoli di vita civile.
PUBBLICITÀ
La sfiducia non prende tanto la strada di una rassegnazione alla cattiva sorte, quanto piuttosto quella di una paradossale determinazione a tagliare i ponti con il passato, perché “indietro non si torna”. In tanti ragionano come se l’umanità si trovasse dentro un tunnel e non avesse altra scelta che addentrarsi nel buio. Sorregge questa visione irragionevole l’idea consolatoria che, senza alcun cambiamento della nostra prospettiva, dalle disavventure e dalle catastrofi attuali usciremo più forti e migliori di prima (attraversate le tenebre si vedrà la luce).
Il pessimismo ottimismo dei nostri giorni ha le sue radici in un periodo recente della nostra storia in cui la qualità della vita e delle nostre relazioni era migliore. Si pensava allora, al riparo dalla nostalgia, che ogni domani non potesse che essere migliore dell’ieri. Sarebbe stato giusto che la naturale preoccupazione sulla tenuta delle conquiste realizzate e la fiducia nel futuro fondata sull’impresa compiuta fossero state usate per il lavoro necessario di manutenzione e per promuovere un processo di consolidamento, espansione e arricchimento del benessere raggiunto (la condizione del suo perdurare). Le conquiste materiali, politiche, culturali e civili esigono un lavoro permanente di trasformazione e di rinnovamento.
Nel momento più riuscito della nostra vita comune, la seconda parte dell’ultimo secolo, invece di impegnarsi nella conservazione e nell’ampliamento delle nostre realizzazioni siamo stati catturati dal mito, già esistente, di un progresso lineare della civiltà e della democrazia. La paura fisiologica di perdere ciò che era stato costruito con dolore e fatica si è convertita silenziosamente dentro di noi nella fede in un “lieto fine” della storia. La fede in un viaggio inarrestabile verso la fine delle nostre difficoltà e delle nostre paure, non poggiava in un progetto politico, ma nell’idea della costruzione tecnologica del futuro (che nonostante tutte le sue formulazioni teoriche resta vaga).
La democrazia ha fatto suo un assunto del capitalismo (la centralità della macchina non solo nella fabbrica ma anche nella costruzione della società e della vita), assoggettandosi gradualmente, senza esserne consapevole, all’ideologia neoliberista (la concezione aggiornata del potere oligarchico, del potere del più forte). Ha favorito l’interiorizzazione del progresso dell’umanità come progresso inarrestabile della tecnologia. La fiducia senza riserve nell’appropriazione tecnica del nostro senso di essere e della realtà muove la nostra fantasia (ma non i nostri passi) verso l’uscita dal pantano in cui siamo arenati. Fantastichiamo un mondo di futura felicità, in cui, contro tutti i dati soggettivi e oggettivi attuali, ogni cosa dovrebbe andare di bene in meglio. Il mito della caverna è capovolto: è stato Platone, il pensiero critico che guarda oltre le apparenze, a imprigionarci nell’oscurità e saranno gli idoli e i dispositivi tecnicamente avanzati a riportarci nella luce, nella libertà.
L’esigenza di costruire un’alternativa all’attuale evoluzione, a dir poco avvilente, della nostra situazione di vita è più forte che mai. Dovremmo fermare l’esponenziale concentrazione della ricchezza (che non solo minaccia estremamente la democrazia, ma è anche totalmente disfunzionale per la nostra sopravvivenza nel mondo); bonificare il nostro rapporto insalubre con l’ambiente; valorizzare la differenza femminile che sta patendo gli effetti barbarici di un processo di sua neutralizzazione; restituire dignità e creatività al lavoro; dare un futuro ai giovani che vivono in un eterno presente. La prospettiva di uno sviluppo sano del nostro modo di vivere è, tuttavia, emotivamente impedita dentro la maggior parte di noi da un riflesso mentale condizionato: ogni deviazione dalla nostra rotta attuale è concepita come ritorno a una deprivazione materiale totale, all’“età della pietra”. Sono considerate come parte dell’età primitiva -in una condensazione psichica della percezione della storia- anche le epoche delle triremi, delle riunioni del demos ad Atene, dei viaggi di Marco Polo, delle carrozze a cavallo, della Comune di Parigi, delle navi a vapore, del telegrafo, dei carteggi epistolari, delle macchine da scrivere, delle sale del cinema, della fiducia nelle aggregazioni politiche, lavorative e culturali.
La storia umana non è un processo lineare, un viaggio di sola andata verso l’avvenire che aggira gli ostacoli e teme le retromarce. È un costante movimento della nostra relazione con il mondo che va a zig-zag e mentre segue la strada di compimento di un suo processo lo lascia, al tempo stesso incompiuto (anche quando temporaneamente lo compie) e si espande lateralmente nello spazio e nel tempo, creando sfasamenti, turbolenze, vortici, sinfonie complesse dei nostri diversi modi di essere, alloggi creativi nella realtà che fanno respirare i nostri desideri, sentimenti e pensieri. Questo movimento non cancella mai lo stato del suo sviluppo precedente, né lo ripete. Lo contiene in sé (come suo passato vivente) ma lo reinterpreta e lo rielabora, facendosi sempre interrogare (e anche destabilizzare) da esso.
Se è vero che è stata la storia a creare la nostra società e la nostra civiltà, è altrettanto vero, è ancora più significativo, che la storia la creiamo noi. Finché ci saremo non ci sarà nessuna fine della storia. Tuttavia, siamo come mai capaci di interrompere il suo movimento e annaspare nella gabbia di un continuo presente
Il culto della tecnologia la converte da strumento indispensabile della costruzione delle condizioni materiali della nostra esistenza a potere significante del nostro modo di sentire, pensare e essere. Questo culto è oggi lo strumento ideologico più potente della legge del più forte che mira all’autoconservazione della sua logica di gestione delle relazioni umane. La legge del più forte segue il principio omeostatico della “coazione a ripetere” il medesimo che ferma il tempo e interrompe il senso e il movimento della storia nella psiche individuale e collettiva.